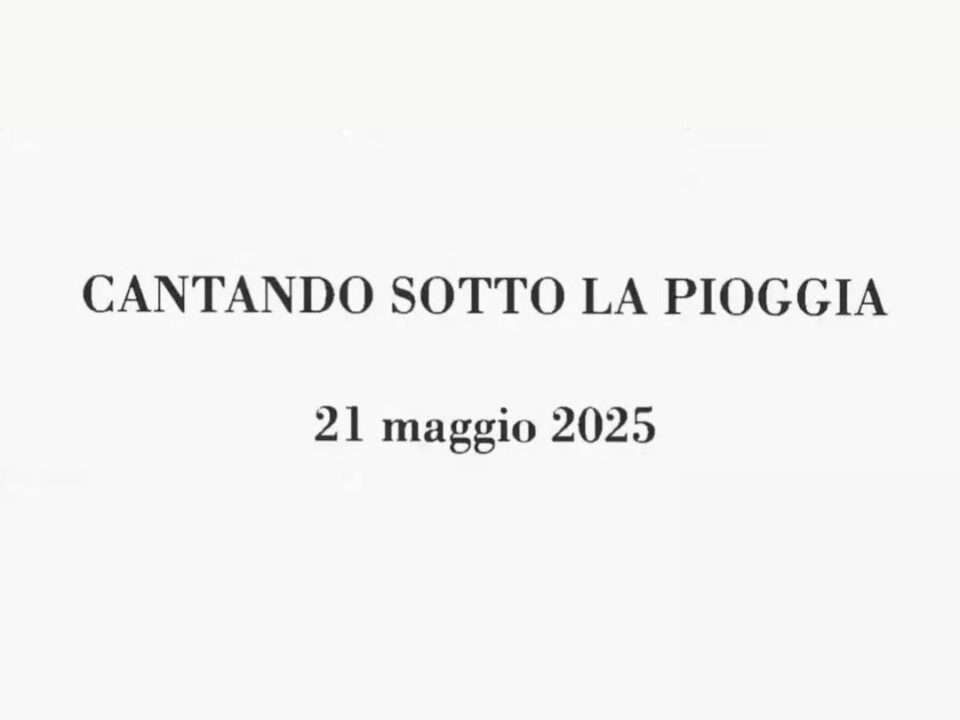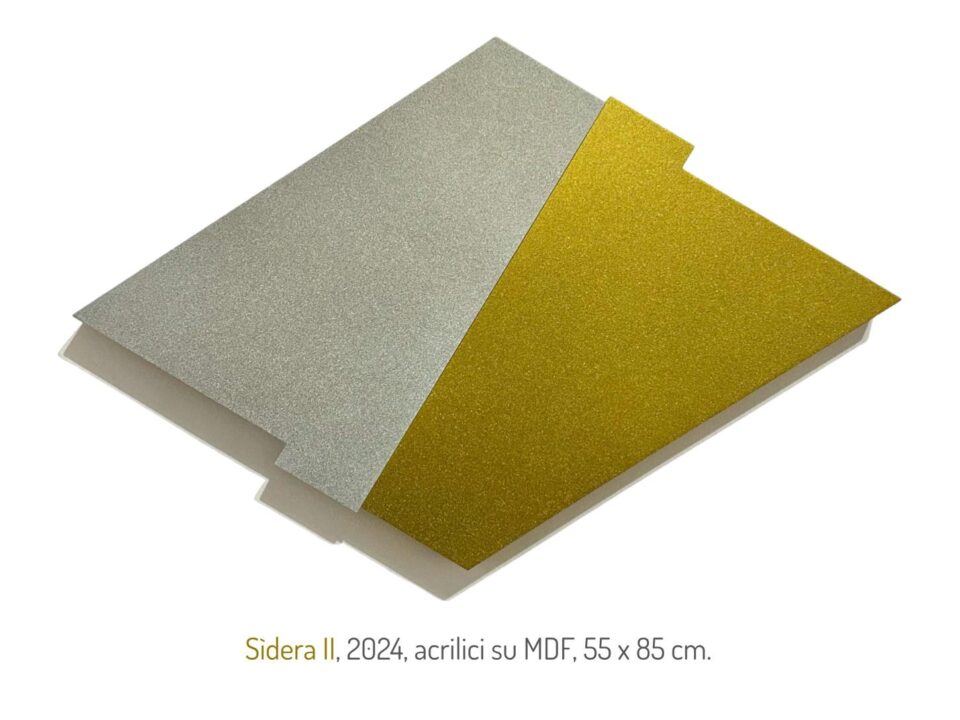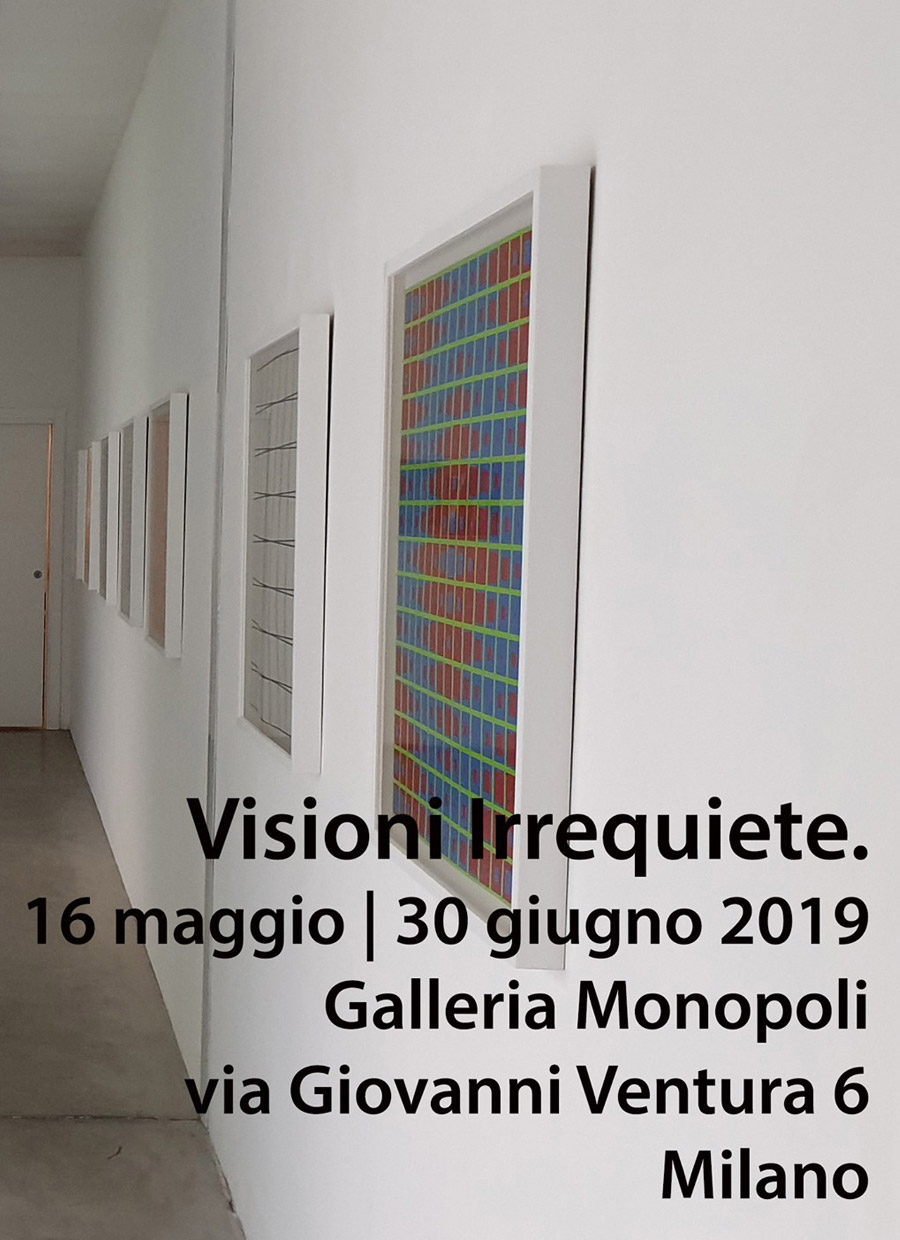
VISIONI IRREQUIETE
16 Maggio 2019
MATTEO NEGRI. ANTIRETORICA
14 Novembre 2019settembre | novembre 2019
A cura di Angela Madesani
Orari di apertura: martedí – sabato | 14.00 – 19.00
La mostra presenta le ricerche di tre artisti, Cioni Carpi (1923-2011), Antonio Paradiso (1936) e
Michele Zaza (1948) inerenti il rapporto tra arte e antropologia.
Non si tratta di un’analisi relativa a gruppi o tendenze, ma di una ricerca trasversale che va a indagare
un particolare momento strettamente legato a un concetto culturale più ampio. Zaza e Paradiso sono
legati a una comune appartenenza geografica, entrambi, infatti, sono nati in Puglia. Per la formazione
culturale di entrambi è importante l’avvicinamento agli studi etnografici di Ernesto De Martino,
scomparso nel 1965, che si era particolarmente interessato alle società contadine del meridione italiano,
attraverso un approccio multidisciplinare, in cui l’immagine svolgeva un ruolo determinante.
Michele Zaza che con Carpi condivide la partecipazione al Padiglione Italia della XXXIX Biennale di
Venezia nel 1980, curato da Vittorio Fagone, ha lavorato sugli archetipi creando con essi un ponte
attraverso la propria famiglia, i ritratti del padre e della madre, presenti in molte delle sue opere del
periodo. Opere realizzate con la fotografia, che ha solo un valore strumentale legato alla registrazione,
alla testimonianza. Nei suoi lavori, così in Dissidenza ignota del 1973, si incontrano, si scontrano il
mondo del quotidiano e il mondo dell’assoluto, attraverso la narrazione presente nell’opera.
Già in quegli anni l’artista pugliese assume posizioni profondamente critiche nei confronti del concetto
di omologazione, con una lettura del circostante oggi più che mai attuale. Il suo, tuttavia, non è un
lavoro di impegno politico, ma di ricerca su temi legati all’universalità dei concetti attraverso un
contatto diretto con la condizione del quotidiano, condizione dalla quale si può trascendere. La sua
opera ha una radice filosofica, di matrice esistenziale che trova diversi punti di riferimento nella opera
di pensatori quali Søren Kierkegaard.
Con lo scorrere del tempo nella sua opera si avverte una dissoluzione degli elementi. «Non esistevano
più il negativo e il positivo, la vita e la morte: tutto si compensava. Per me era importante
rappresentare, unificare il senso dell’uomo e della natura e viceversa. Questa è una presa di coscienza
mentale, non un fatto reale, certe libertà si possono vivere solo a livello mentale», spiegava l’artista a
chi scrive alcuni anni fa.
In un testo del 1977 pubblicato in Teatro antropologico Antonio Paradiso scrive: «L’arte
antropologica si trova tra una storia dell’arte che non c’è mai stata e una storia dell’arte che non c’è
ancora, per questo si deve fare dell’arte». L’arte del presente, dell’immanenza su cui Paradiso ha
lavorato in quegli anni con grande impegno da Natura e usura ai Tarantati a Toro e mucca meccanica
a Teatro antropologico, appunto, utilizzando diversi linguaggi dal cinema alla fotografia, alla scultura.
Per questo ha viaggiato alla ricerca delle radici dell’uomo dal sud dell’Italia all’Africa.
Del 1972 è la sua Storia naturale del quaternario in cui si pone alla ricerca dei primordi, delle
preistorie dimenticate. Come ha sottolineato Guido Ballo proprio in quella importante pubblicazione la
ricerca di Paradiso si fonda su un ritorno alla “grande madre”. Grande madre alla radice delle civiltà,
delle culture, dei primi vagiti della filosofia.
Il cammino artistico di Cioni Carpi, uomo di idee, è lontano da quello di Zaza e Paradiso. Di parecchi
anni più vecchio di entrambi, la sua vicenda personale ha fortemente segnato la sua parabola artistica.
L’uccisione di un fratello minore, in un campo di concentramento tedesco, ad opera dei nazi-fascisti ha
determinato delle scelte fondanti per la sua ricerca, lo studio dell’uomo, del suo comportamento,
perlopiù inspiegabile. Sono le sue, indagini di matrice comportamentale che di rado riescono a trovare
delle risposte. Nei lavori fotografici Carpi è quasi sempre protagonista, performer sui generis di azioni
che vanno a indagare il senso recondito dei fenomeni. Carpi, del resto, negli anni Cinquanta studia
mimo con Jacques Lecoq al Piccolo Teatro di Milano. L’uomo, la natura, l’ambiente sono al centro dei
suoi interessi.
Il suo cinema, realizzato a partire dalla fine dei Cinquanta fino ai Settanta, influenzato dalla lezione
della regista sperimentale Maya Deren, ha per oggetto indagini di matrice comportamentale in cui il
forte ha sempre la meglio sul debole. Vi è sempre una lotta tra la vita per l’uomo e la vita contro
l’uomo, tra quella desiderata e quella imposta dalle contingenze politiche, sociali, culturali dove è
difficile trovare una via di scampo.